
BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000
Aggiornato:

Aggiornato:

19/1/2013 ● Solitudini d'autore
Il frammento
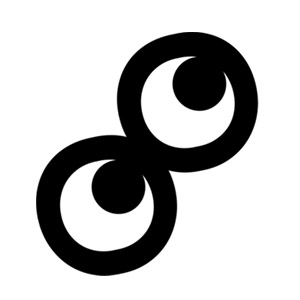 Redazione FPW ● 1915
Redazione FPW ● 1915
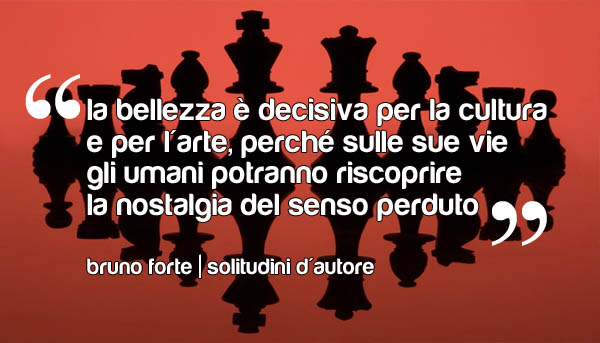
(...) Come ha detto Ravasi, intento
della mostra - intitolata "Lo splendore della verit√†, la bellezza della carit√†" - √® ¬ęapprofondire la ricerca
di un dialogo che si è interrotto, quello tra arte e fede, che insieme in
passato hanno prodotto grandi capolavori, ma le cui strade da tempo si sono divaricate... Si tratta di un dialogo necessario, vista
la parentela di questi due aspetti dell'animo umano che, su strade diverse,
tendono entrambi all'infinito¬Ľ.
Come e perché? La risposta che vorrei dare parte dalla meditazione di Hans Urs
von Balthasar - una delle menti pi√Ļ alte del cosiddetto "secolo breve", oltre
che uomo di straordinaria erudizione - per il quale il bello è l'offrirsi del "Tutto nel frammento" ("das Ganze im Fragment"),
l'evento di una donazione che supera l'infinita distanza. Come può l'infinito
abitare in ciò che è minimo? O l'eterno abbreviarsi senza annullarsi? O l'immenso contrarsi senza negarsi? La risposta
che una vasta tradizione del pensiero occidentale dà a queste domande è che
questo è possibile o mediante la proporzione della forma, che riproduca l'armonia del Tutto - formosus è il
bello! -, o attraverso lo splendore, per cui il Tutto irraggia nel frammento per
via d'irruzione e di rapimento: speciosus,splendido è il bello!
Nel primo caso, il Tutto può dimorare nel frammento in quanto questo si offra
come determinazione spazio-temporale dell'infinito grazie alla riproduzione
della corrispondenza dei rapporti: è l'idea della bellezza classica, consacrata specialmente dai capolavori della Grecia
antica e assunta dall'anima cristiana di Agostino, ad esempio nel suo De Musica.
Nel secondo caso, il Tutto irrompe nel frammento come movimento che sorge dall'alto o dal profondo, e schiude una
finestra verso l'illimitato, sì che il minimo appaia come "abbreviazione"
dell'eternità nel tempo, dell'infinito nel finito.
√ą la meditazione che ha portato a considerare la bellezza come "bonicellum",
piccolo bene, "verbum abbreviatum" dell'eterno splendore di Dio: da questa
considerazione cristiana medioevale si forma in tutte le lingue romanze il termine per dire la bellezza ("bello" in
italiano, "bonito" nelle lingue della penisola iberica, "beau" in francese e
"beautiful" in inglese). Qui l'anima greca s'incontra con la novità cristiana.
Qui il cristianesimo assume e tradisce Atene, perché - mentre aspira anch'esso a
contemplare il Tutto nel frammento - confessa che l'evento della bellezza si è
compiuto una volta per sempre nel giardino fuori di Gerusalemme, dove sulla roccia del Calvario sta la Croce della
bellezza. √ą convinzione essenziale della fede cristiana che il Verbo eterno si
dica in questo mondo per via della contrazione suprema, grazie all'atto per il quale - in nulla costretto
dall'infinitamente grande - il Figlio si è lasciato contenere dall'infinitamente
piccolo.
Veramente divino √® questo contrarsi: "Non co√ęrceri maximo, contineri tamen a
minimo, divinum est" - "Non essere costretti dal pi√Ļ grande, ma lasciarsi
contenere dal pi√Ļ piccolo, questo √® divino"(la frase, "elogium sepulcrale" di Sant'Ignazio di Loyola, √® stata usata da
Hölderlin nel 1794 come esergo al frammento di romanzo Hyperion)! Questa estasi
del divino √® al tempo stesso l'appello pi√Ļ alto che si possa concepire all'estasi dal mondo, a quel trasgredire verso il
mistero che è il rapimento della bellezza che salva, reso possibile appunto
dall'"abbreviarsi" del Verbo nella carne. Il Tutto dimora nel frammento, l'infinito irrompe nel finito: il Dio Crocifisso è
la forma e lo splendore dell'eternità nel tempo. Sulla Croce il "Verbum
abbreviatum" - "kenosi" del Verbo eterno - rivela la bellezza come dono di amore e offerta di senso e di speranza per tutti!
Perché questo è così importante per noi, donne e uomini del "post-moderno"? E
perché al servizio di questa causa fede e arte devono lavorare insieme? Dopo
l'utopia delle grandi visioni ideologiche, assetate di totalità e divenute totalitarie e violente nei loro effetti storici,
la grande tentazione è la decadenza, la rinuncia a pensare in grande e a sognare
e impegnarsi per un domani pi√Ļ bello per tutti, degno dell'umano che √® in noi. A questa tentazione occorre reagire
offrendo orizzonti di senso e di speranza, che non siano asfissianti come quelli
delle ideologie: occorre riconoscere il Tutto nei frammenti della vita e dell'opera dei giorni. √ą a questo precisamente che educa
la bellezza: essa è perciò decisiva per la fede, chiamata a riscoprire come
Colui in cui si crede, oltre a essere il vero e il bene, sia il bello da amare e da cui lasciarsi amare, capace di dare senso alla
vita. E la bellezza è decisiva per la cultura e per l'arte, perché sulle sue vie
gli umani potranno riscoprire la nostalgia del senso perduto e cercarla in forme non violente come quelle della ragione
ideologica, ma tanto vere, quanto umili e vivificanti.
√ą insomma la bellezza a operare quel miracolo, che Mario Luzi - altissima voce
poetica del Novecento - chiam√≤ ¬ęil battesimo dei nostri frammenti¬Ľ.
Chi di noi può dire di non averne veramente bisogno?
di Bruno Forte, "Tra fede e arte dialogo riaperto" in ‚ÄúIl Sole 24 Ore‚ÄĚ del 3 luglio 2011
