
BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000
Aggiornato:

Aggiornato:

20/5/2014 ● Solitudini d'autore
Tra economia e cultura (l'Arte di produrre Arte)
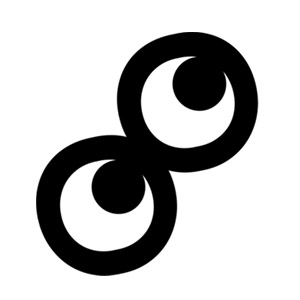 Redazione FPW ● 1559
Redazione FPW ● 1559
Le relazioni tra economia e cultura sono espresse nella Convenzione Unesco,
2007, al fine di favorire la protezione e la promozione della diversità di
espressioni culturali. L’articolo 2, sancisce il principio della
complementarietà , nonché della funzionalità reciproca tra gli aspetti economici
e culturali dello sviluppo di un paese, evidenziando come sia sostanzialmente
«mozzato» un qualsiasi approccio alla conoscenza che non parta dall’assunto che
non può prodursi sviluppo economico senza sviluppo culturale e viceversa.
Eppure, nell’interazione tra economia e cultura prevale ancora troppo spesso un
approccio teorico da parte degli economisti, che pur riconoscendo l’esistenza di
questo rapporto, spesso, ne danno una lettura piuttosto «miope» non riuscendo a
definire le influenze che la cultura esercita nel sistema economico di una
nazione. La giustificazione risiede spesso nella «pretestuosa» mancanza di dati
e di indicatori necessari all’interpretazione, valutazione e misurazione dell’
impatto che la cultura genera sul sistema economico. Un ramo della teoria
economica ancora poco sviluppato, poiché comporta uno spostamento dall’asse
econo-centrica della visione globale ancora in larga misura prevalente.
Ciò nonostante l’imprescindibilità del rapporto tra economia e cultura è
crescente e a dimostrarlo sono, per esempio, i mutamenti in atto nei paesi
emergenti che hanno sostenuto il principio dello sviluppo, pur sempre basato
sulle moderne teorie economiche occidentali (competitività , innovazione
tecnologica, elevati investimenti, orientamento all’esportazione,
specializzazione delle risorse umane, ecc), riconoscendo però il valore del
radicamento culturale locale e conservatore delle identità territoriali (fede,
valore della famiglia, rispetto della disciplina e dell’autorità , etica del
lavoro, riconoscimento del valore della creatività e della produzione culturale,
innovazione e coesione sociale). Il successo di questi paesi è ormai un dato di
fatto, collocandosi questi ai vertici della scala economica globale,
sconfessando così lo scetticismo di alcuni economisti sul reale apporto dei
fattori culturali.
[...] Il terzo Rapporto Symbola, autori Fondazione Symbola e Unioncamere,
è una fotografia sull’industria culturale italiana che racconta di un’economia
italiana che per il 54% poggia sul 458mila imprese e quasi un milione e 400mila
addetti tra industrie creative, culturali, patrimonio storico-artistico e arti
visive cui si affianca il sistema culturale della Pa e il non profit di
associazioni e fondazioni. Il valore del rapporto sta nella capacità di mettere
a sistema un numero elevato di dati sul tema dell’industria culturale e
creativa, valorizzando il patrimonio informativo di dati Unioncamere. I focus
particolarmente interessanti sono quello sul turismo in relazione alla capacitÃ
di attivazione che le industrie culturali producono sulla spesa turistica,
quello sulla formazione nel management culturale che ha approfondito in
particolare le relazioni tra il sistema formativo e il mercato delle
professioni, declinando il concetto di competenza afferente alla figura del
manager culturale. Infine, una nuova elaborazione che riguarda il calcolo del
moltiplicatore della cultura, che quantifica il prodotto generato a partire da
un valore di produzione rilevato nel perimetro delle attività del sistema
produttivo culturale. Insieme al Rapporto merita di essere citato anche un altro
volume, I.T.A.L.I.A, geografie del made in Italy, scaricabile anch’esso nella
homepage del sito di Fondazione Symbola che introduce ad un’altra discussione:
se, in tempo di crisi, a «governare» è il capitalismo della conoscenza e delle
reti, «l’X-factor» nella produzione di valore dipenderà sempre più dalla
capacità delle imprese di produrre, in modo condiviso ed etico quei beni comuni
dell'identità , del paesaggio, della coesione sociale, della sostenibilità che
alimentano la distintività del made in Italy sui mercati globali. Questo volume
traccia attraverso un interessante storytelling le prime proteine di un nuovo
DNA, espressione della contemporaneità in cui cultura e manifattura si innestino
reciprocamente, affinché l’economia della cultura possa produrre quei
moltiplicatori del valore che soli gli consentono di fungere da volano anche per
il resto del sistema produttivo.
[...] Civita ha pubblicato un rapporto intitolato l’Arte di produrre Arte.
Imprese culturali a lavoro. Il volume curato da Pietro Antonio Valentino,
edito da Marsilio, è stato anch’esso realizzato dal Centro Studi «G. Imperatori»
dell’Associazione Civita con il contributo della Fondazione Roma Arte-Musei e
della Provincia di Roma. Esso descrive il quadro delle attività economiche
legate alla produzione o all’uso della cultura e della creatività in Italia.
Anche in questo caso centrale è il tema della misurazione (dimensione delle
imprese CC e impatti economici che generano anche a confronto con gli altri
Paesi europei). Una fotografia esauriente di debolezze e potenzialità esplorate
del settore in Italia, in confronto con gli altri Paesi europei: parola d’ordine
l’innovazione. La pubblicazione è strutturata in due parti: una prima, in cui si
dà conto di ruolo e dinamiche dell’Industria Culturale e Creativa (ICC); una
seconda, dove vengono analizzate le caratteristiche della domanda museale in
Italia, con particolare attenzione ai «non visitatori», e stimati gli impatti
economici più rilevanti associati alle mostre.
[...] Nel rapporto che lega economia e cultura un tema emergente è poi quello
dell’innovazione sociale a base culturale. Darne una definizione precisa è
difficile e probabilmente fuorviante perché agendo su un territorio vasto quale
quello dell'Europa e dei suoi vicini, l’innovazione sociale coincide più con un
modo di pensare emergente fondato su un’attiva partecipazione della società , dei
cittadini. Quindi richiede al cittadino di non essere semplicemente consumatore,
ma di partecipare allo sviluppo e all’implementazione, oltre che alla
definizione iniziale del problema da risolvere [...].
[...] Il contributo parte da una costatazione: il mondo culturale nonprofit si
regge economicamente, per la maggior parte, su trasferimenti, il 90% di questi
sono pubblici, ma il loro ammontare è sceso in modo permanente. I trasferimenti
europei, dalle fondazioni, da liberalità e sponsorizzazioni non possono
compensare questa caduta. Quindi, il mondo culturale deve pensare a come vivere
in questo nuovo «equilibrio». La soluzione salvifica non esiste, è invece
opportuno perseguirne molte assieme: aumentare le entrate «di mercato»
(bigliettazione, attività collaterali), aumentare il ricorso ai volontari,
ridurre in generale i costi, al limite fondere organizzazioni e comunque
inserirsi in reti, professionalizzare il management, intensificare la raccolta
fondi, sfruttare il patrimonio esistente di proprietà o comunque accessibile
(«federalismo demaniale»), ricorrere alla finanza esterna di debito, se
possibile di capitale, e di progetto (project financing anche all’interno di
partnership pubblico-privato). In sintesi, per sopravvivere, le organizzazioni
del mondo culturale devono accentuare la propria anima di impresa, al di là che
la forma giuridica prescelta sia for-profit o rimanga associativa, cooperativa,
fondazionale o perfino pubblica. Il settore pubblico deve esercitare una
funzione di facilitazione, all’interno di tavoli e partnership con il privato
incluso il nonprofit. Sul versante patrimoniale, la fonte finanziaria principale
delle organizzazioni culturali è oggi il debito, soprattutto bancario (forse
€900 mln di affidamenti al nonprofit culturale). Gli spazi di miglioramento
della relazione fra organizzazioni culturali e banche sono, però, ancora ampi.
Intanto la qualità della relazione, testimoniata da una ricerca ad hoc della
«Sapienza»,, è bassa e inferiore a quella media del nonprofit; va sviluppata una
metodologia di analisi specifica del merito di credito nel settore culturale; si
può approfondire il ruolo dei fondi di garanzia, a partire dalla creazione di
facility a valere sui €210 mln già destinati nell’ambito di Europa Creativa.
Infine, si può sviluppare il debito raccolto dal pubblico generale (crowdfunding
in versione social lending), anche attraverso piattaforme innovative come Terzo
Valore.
Giorgia Turchetto (Direttore Master Digital Heritage Università La Sapienza)
| L'imprescindibilitÃ
del rapporto tra economia e cultura
