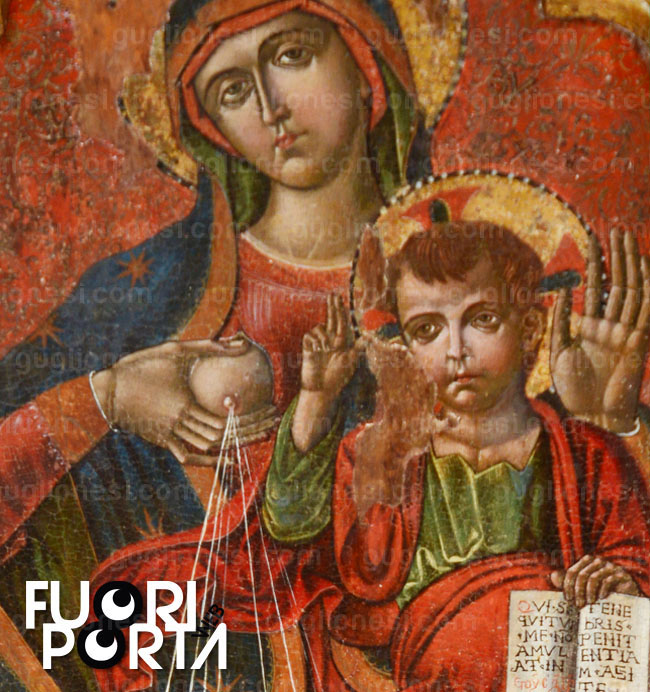BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000
Aggiornato:

Aggiornato:

26/6/2015 ● Cultura
Nel latte il nutrimento della "penitenza" verso la "salvezza"
 Luigi Sorella ● 4557
Luigi Sorella ● 4557
Nel cibo della vita, come nutrimento spirituale, la parola “latte” non
appartiene culturalmente alla dottrina dei vangeli canonici di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Compare nel richiamo al nutrimento del nascituro, per esempio,
con la Lettera ai Corinzi di San Paolo: “Vi ho dato da bere latte, non
cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete”
[1Cor 3,2].
Paolo, inoltre, cita il latte anche nella Lettera agli Ebrei: “Infatti
voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete ancora
bisogno che qualcuno v'insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete
diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di
latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora un
bambino” [Eb 5,12-13].
Esplicita allusione dottrinale al latte, irrinunciabile nutrimento per la
“salvezza” umana, proviene da una emblematica lettera di San Pietro: “Come
bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al
quale voi possiate crescere verso la salvezza” [1Pt 2,2].
Nel percorso di crescita verso la salvezza va contestualizzata l’iconografia
della “Madonna delle Grazie” del crivellesco Michele Greco da Valona
[trittico tempera su tavola “Madonna con il Bambino tra i Santi Sebastiano e
Rocco”, 1505, Collegiata di Santa Maria Maggiore in Guglionesi], localmente
nota anche come la “Madonna del latte”.
In realtà la “Madonna del latte” (la galactotrofusa, in latino Madonna
lactans o Virgo Lactans), nell’iconografia cristiana fa riferimento
alla Madre che nutre il suo divino Bambino, ed è assai ricorrente culturalmente
nella pittura in generale. L’interpretazione artistica, invece, della Madonna
che dona fiotti di latte alle anime del Purgatorio – appunto l’iconografia delle
“Grazie” – è alquanto rara.
Il raccordo del racconto pittorico, nel comparto centrale del
trittico di Guglionesi, avviene sulla verticalità creativa, in fondo alla quale c’è,
concepito di uguaglianza spirituale, tutto il genere umano nella propria
nuditĂ penitenziale, tra le fiamme del purgatorio.
I Santi hanno nutrito la loro vita con la penitenza, il vero cibo della
“salvezza”. Nel trittico di Guglionesi, l’opera di Michele Greco di Valona
presenta, come prima figura umana a sinistra, sotto il trono della Vergine in
atto di concessione delle Grazie, un primo fiotto di latte che raggiunge
certamente un Santo (in riferimento alla committenza della confraternita
patronale di Guglionesi: ipotesi di profilo di guida e di intercessione
patronale della comunità ?), riconoscibile dall’aureola raggiante attorno al suo
capo. E, come si evince da una lettura piĂą approfondita del messaggio
iconografico dell’opera, ogni anima, dai chierici (si noti la testa di taluni
figuranti) ai bambini, dagli uomini alle donne, volge alla Madonna la propria
invocazione di nutrimento.
Nella raritĂ tematica del capolavoro d'arte cinquecentesca di Guglionesi la
Vergine nutre le anime con il Suo latte, indicando il Figlio e annunciando le parole
evocate dal libro sacro: “Qui sequitur Me non ambulabit in tenebris –
Penitentiam agite”. Cioè: “Chi segue Me non abita nelle tenebre” [Gv
8,12]. Ed ecco, a conclusione della lettura iconografica dell’intera opera, giunge alla cristianitĂ
l’esortazione di Giovanni Battista nel deserto: “Agite con la penitenza”.

La figura del Santo con aureola.

Le anime del Purgatorio.